 |
Pagina Web a cura della Linea di Ricerca su Protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, radiofrequenza e microonde. |
 |
Conferenza pubblicaI CAMPI ELETTROMAGNETICILugano, 23 novembre 2000 |
 |
Pagina Web a cura della Linea di Ricerca su Protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, radiofrequenza e microonde. |
 |
Conferenza pubblicaI CAMPI ELETTROMAGNETICILugano, 23 novembre 2000 |
Allo stato attuale, le applicazioni dei CEM e le altre tecnologie che comunque portano a disperdere CEM nell'ambiente investono numerosissimi settori della società.
In ambito industriale, i campi elettromagnetici sono impiegati in molti processi produttivi per ottenere un riscaldamento rapido ed efficiente: per la tempra ed altre lavorazioni sui metalli, per la saldatura di materiali plastici e l'incollaggio del legno, per la disinfestazione di prodotti alimentari o manufatti artistici, per la cottura degli alimenti e l'essiccazione di materiale ceramico.
In ambito sanitario, la marconiterapia e la radarterapia sono note applicazioni terapeutiche basate sul riscaldamento indotto dai campi elettromagnetici.
Sorgenti di campi elettrici e magnetici a bassissima frequenza (elettrodomestici, macchine da ufficio) e di campi elettromagnetici a radiofrequenza (telefoni cordless, antifurto, ) sono presenti negli ambienti domestici e di ufficio.
Numerosissime infine le sorgenti nell'ambiente esterno: accanto a elettrodotti e stazioni radiobase per la telefonia cellulare, strutture ben note e costantemente al centro di polemiche e dibattiti, abbiamo gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli apparati per supporto e controllo del traffico aereo, i ponti radio e le reti di telecomunicazione specializzate.
La tabella seguente elenca le principali classi di sorgenti ambientali di campi elettromagnetici, distinguendo tre bande di frequenza secondo una terminologia ("basse frequenze", "frequenze intermedie" e "alte frequenze") non proprio rigorosissima ma che è entrata nel linguaggio comune ed ha anche avuto un certo riconoscimento nell'ambito del progetto europeo COST-244-bis. Per ogni sorgenti viene indicato se l'emissione di campi elettromagnetici sia una conseguenza accidentale del funzionamento della sorgente, oppure ad essa funzionale. Viene anche indicato se la sorgente emette prevalentemente campo elettrico, magnetico o elettromagnetico.
| Banda di frequenza | Sorgente | Tipo di emissione |
Campi emessi |
|
| Basse frequenze |
fino a 3 kHz |
Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (centrali, cabine, elettrodotti aerei ed interrati) | Accidentale | Elettrico e magnetico |
| Utilizzo dell'energia elettrica (impianti elettrici ed apparecchi utilizzatori) | Magnetico | |||
| Varchi magnetici (sistemi antifurto e per la rilevazione dei transiti) | Intenzionale localizzata | |||
| Frequenze intermedie |
da 3 kHz a 3 MHz |
Sistemi domestici per la cottura ad induzione magnetica (frequenze tipiche 25 ¸ 50 kHz, potenze dell'ordine di qualche chilowatt) | Intenzionale localizzata | Magnetico |
| Varchi magnetici (sistemi antifurto e per la rilevazione dei transiti) | ||||
| Emittenti radiofoniche a onde medie | Intenzionale a diffusione | Elettrico e magnetico | ||
| Alte frequenze |
oltre 3 MHz |
Varchi magnetici (sistemi antifurto e per la rilevazione dei transiti - fino a 10 MHz) | Intenzionale localizzata | Magnetico (ed elettrico) |
| Emittenti radiofoniche a modulazione di frequenza (88 ¸ 108 MHz) | Intenzionale a diffusione | Elettro-magnetico | ||
| Emittenti televisive VHF e UHF (fino a circa 900 MHz) | ||||
| Stazioni radiobase per la telefonia cellulare (900 MHz e 1800 MHz circa) | ||||
| Ponti radio | Intenzionale focalizzata | |||
| Radioaiuti alla navigazione aerea (radar, radiofari) | ||||
La figura mostra il profilo laterale del campo elettrico a 50 Hz prodotto al suolo da un elettrodotto aereo 380 kV semplice terna da 1000 MW (1500 A), a partire dall'asse della linea fino a 200 m di distanza, con altezza dal suolo del conduttore più basso di 7.78 m (valore minimo sul terreno e su specchi d'acqua non navigabili ammesso dalla normativa italiana DMLP 16 gennaio 1991) e di 40 m (assunto come valore massimo).
Nel primo caso (curva rossa, altezza 7.78 m) il campo elettrico raggiunge una intensità massima di circa 9200 V/m. Nel secondo caso (curva azzurra, altezza 40 m) il valore massimo è di circa 500 V/m.
Si ricorda che il limite massimo attualmente previsto dalla legislazione italiana per le esposizioni prolungate ("una parte significativa della giornata") della popolazione è di 5000 V/m, che divengono 10000 V/m per le esposizioni più brevi. L'intensità resta sotto i 5000 V/m solo se l'elettrodotto ha una altezza minima dal suolo di almeno 11 metri, ed in effetti 11.34 m è la minima altezza consentita dal DMLP del 1991 sul terreno "popolato".
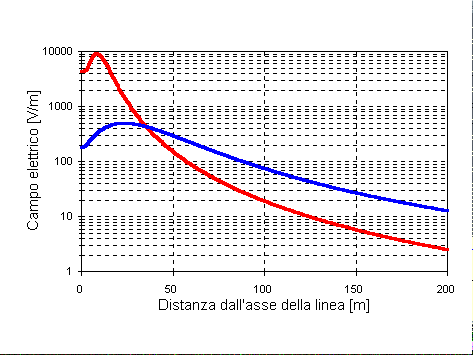
La figura mostra il profilo laterale del campo magnetico a 50 Hz prodotto al suolo da un elettrodotto aereo 380 kV semplice terna da 1000 MW (1500 A), a partire dall'asse della linea fino a 200 m di distanza, con altezza dal suolo del conduttore più basso di 7.78 m (valore minimo sul terreno e su specchi d'acqua non navigabili ammesso dalla normativa italiana DMLP 16 gennaio 1991) e di 40 m (assunto come valore massimo).
Nel primo caso (curva rossa, altezza 7.78 m) il campo magnetico raggiunge una intensità massima di circa 36 µT (sull'asse della linea) mentre il tanto citato valore di 0.2 µT si raggiunge a circa 139 m dall'asse. Nel secondo caso (curva azzurra, altezza 40 m) il valore massimo è di circa 2.3 µT e la distanza per gli 0.2 µT scende a 133 m.
Si ricorda che il limite massimo attualmente previsto dalla legislazione italiana per le esposizioni prolungate ("una parte significativa della giornata") della popolazione è di 100 µT.

La figura mostra il campo magnetico generato al livello del suolo da un elettrodotto 380 kV doppia terna piana da 1000 MW (790 A) interrato ad una profondità di 1.85 metri. Come si vede, il campo magnetico massimo (pari a circa 14.5 µT) è confrontabile con quello dell'elettrodotto in aria, tenendo conto del diverso livello di corrente trasportata (circa la metà). Esso però si riduce più rapidamente con la distanza: gli 0.2 µT si raggiungono a soli 24 metri circa dall'asse della linea.
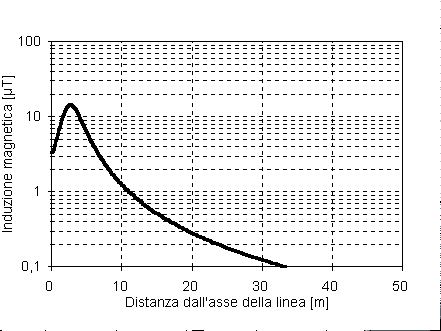
All'IROE abbiamo eseguito diverse campagne di misura del campo magnetico a 50 Hz in ambienti abitativi. Dall'analisi dei dati rilevati fino ad oggi sono emerse alcune considerazioni abbastanza generali.
Queste considerazioni sono ben documentate dalla figura, che riporta e confronta le misure di induzione magnetica eseguite su un arco di 20 ore, una misura ogni 5 minuti, in un punto di un tipico appartamento in condominio urbano (linea superiore) e di una abitazione singola in quartiere periferico semirurale (linea inferiore).
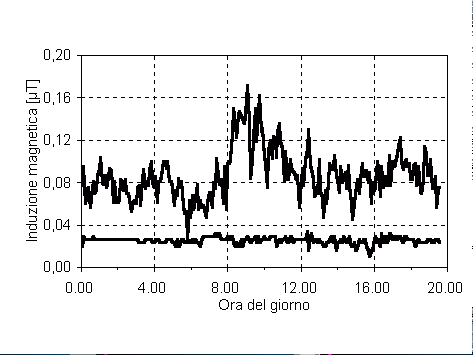
All'IROE sono state eseguite anche delle serie di misure del campo magnetico a 50 Hz generato da numerosi piccoli elettrodomestici di uso comune. In figura sono riportati, a titolo di esempio, i dati rilevati su di un asciugacapelli (linea in colore azzurro) e uno spremiagrumi (linea in colore rosso), ma le conclusioni che riportiamo sono abbastanza generali.
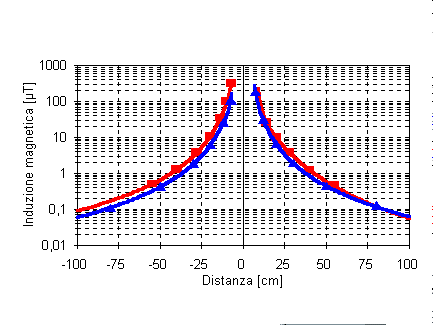
La tabella che segue prende in considerazione le principali classi di sorgenti di teleradiodiffusione operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0.1 MHz e 3 GHz. Per ciascuna classe si riportano i valori tipici di frequenza, di potenza in antenna, di guadagno e di EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power, data dal prodotto tra potenza in antenna e relativo guadagno).
| Tipo | Frequenza | Potenza | Guadagno | EIRP |
|---|---|---|---|---|
| Emittenti radio AM | 500 ÷ 1600 kHz | 1 ÷ 500 kW | poche unità | 1 ÷ 500 kW |
| Emittenti radio FM | 88 ÷ 108 MHz | 1 ÷ 12 kW | 5 ÷ 50 | 10 ÷ 500 kW |
| Emittenti TV | VHF I-II: 52.5 ÷ 88 MHz
VHF III: 174 ÷ 223 MHz UHF IV: 470 ÷ 590 MHz UHF V: 614 ÷ 838 MHz |
0.1 ÷ 1 kW | 1 ÷ 100 | 5 ÷ 100 kW |
| Stazioni RB (downlink) |
eTACS: 910 ÷ 950 MHz
GSM: 925 ÷ 960 MHz DCS: 1805 ÷ 1880 MHz |
30 ÷ 300 W | 3 ÷ 30 | fino a 2 kW |
 |
| Antenne radio AM presso Firenze |
La figura seguente riporta la distanza dal centro elettrico della sorgente a cui si raggiunge il limite di 20 V/m (linea azzurra) oppure di 6 V/m (linea rossa) in funzione del valore di EIRP della sorgente, nella direzione di massimo irraggiamento della stessa.
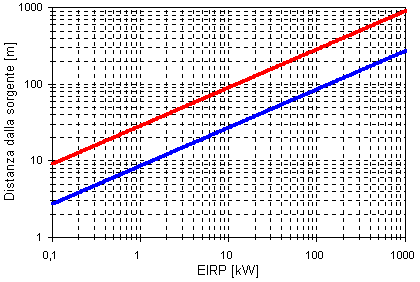
 |
| Il sito di trasmettori radio-TV di Monte Serra, presso Pisa |
Le figure seguenti prendono in considerazione il problema della presenza simultanea delle emissioni di più stazioni radio e TV. Le figure riportano dati rilevati in prossimità del sito di Monte Serra (e precisamente sulla cima di Monte Cascetto, un colle posto a circa 1 km dall'area degli impianti). Quello di Monte Serra è uno dei più significativi siti di impianti di teleradiodiffusione in Toscana. Le misure riguardano l'intervallo di frequenza da 88 a 900 MHz e sono state eseguite utilizzando una antenna biconica Ailtech 94455-1 (per la banda da 88 a 200 MHz) e una antenna a spirale conica logaritmica Ailtech 93490-1 (per la banda da 200 a 900 MHz), collegate ad uno spettroanalizzatore Hewlett & Packard 8567A.
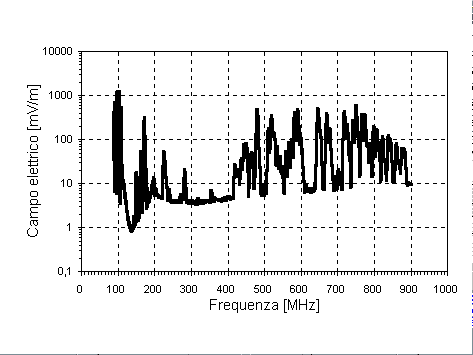
La figura illustra la situazione panoramica dell'intera banda 88 ÷ 900 MHz. Il corrispondente valore complessivo del campo elettrico (somma quadratica) è di circa 6 V/m (per confronto, il valore misurato con uno strumento a larga banda è di 0.02 mW/cm2, pari a 8.7 V/m), imputabili soprattutto alle emittenti FM (88 ÷ 108 MHz - 5.5 V/m), in secondo luogo alle TV-UHF (450 ÷ 850 MHz - 2.2 V/m) e per la parte rimanente ad altre emittenti (TV-VHF o altro, 0.6 V/m). Un semplice calcolo mostra che la distanza a cui si raggiungono i 20 V/m complessivi è di circa 300 m dall'area del sito.
Nella seguente tabella sono riportate le bande di frequenza impiegate per i principali servizi di telecomunicazione in Italia.
| Servizio | Banda di frequenza (approssimativa) |
Note |
|---|---|---|
| Radio AM | 500 - 1600 kHz | Radiodiffusione RAI a onde medie |
| TV VHF-I/II | 50 - 88 MHz | Canali RAI 1 |
| Radio FM | 88 - 108 MHz | RAI e private a modulazione di frequenza |
| TV VHF-III | 170 - 220 MHz | Canali RAI 1 |
| TV UHF-IV/V | 470 - 850 MHz | RAI 2 RAI 3 ed emittenti private |
| Telefonia eTACS | 870 - 950 MHz | Cellulari "analogici" |
| Telefonia GSM | 880 - 960 MHz | Cellulari digitali europei |
| Telefonia DCS | 1710 - 1880 MHz | Cellulari "dual band" |
| Telefonia UMTS | 1900 - 2170 MHz | Cellulari "3G" |
Come si può vedere, esiste una notevole contiguità tra le più alte frequenze impiegate dalla TV e quelle della telefonia cellulare più classica (eTACS e GSM); è lecito aspettarsi quindi che anche gli eventuali effetti biologici e sanitari siano confrontabili (a parità di intensità del campo), anche se la struttura del segnale (cioè il tipo di modulazione) nei due casi è abbastanza diversa.
Le antenne trasmittenti impiegate nelle stazioni radio base (SRB) della telefonia cellulare sono di vario tipo. Una classificazione sommaria porta a distinguere tra antenne omnidirezionali (o a basso guadagno) ed antenne settoriali (o ad alto guadagno), come indicato schematicamente nella sottostante figura, tratta dal sito Internet Cellular Phone Antennas (Base Stations) and Human Health di J.Moulder.
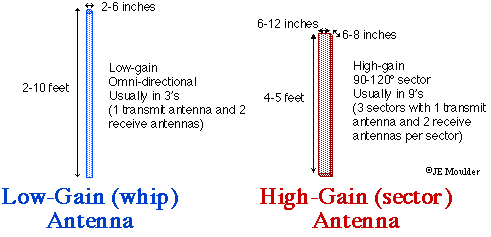
Mostriamo alcune tipologie di antenne settoriali per stazioni radio base, con immagini tratte dal sito Internet di M.Scatà Global System for Mobile communications.
 |
 |
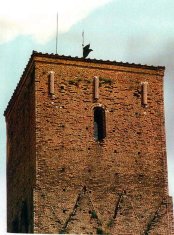 |
Un tipico pannello trasmittente per SRB può avere per esempio un guadagno di 17 dB, il che signfica che irradia nella direzione di massimo circa 50 volte di più di un radiatore isotropo, a pari potenza di alimentazione. Le larghezze del fascio irradiato a metà potenza sul piano orizzontale e sul piano verticale possono essere rispettivamente dell'ordine di 60 ÷ 90o e di 5 ÷ 15o, ma vi è molta variabilità a seconda delle specifiche esigenze; per quanto riguarda la direzione di puntamento, essa è orizzontale o lievemente inclinata verso il basso ("tilt", anch'esso dell'ordine di 5 ÷ 15o).
Nell'esempio mostrato nelle figure che seguono, si fa riferimento ad una SRB installata su un traliccio alto 3 m, posto sulla sommità di un edificio di cinque piani (alto quindi circa 15 m); la stazione utilizza un pannello trasmittente con aperture a metà potenza di 10o sul piano verticale (con 6o di tilt) e di 65o sul piano orizzontale.
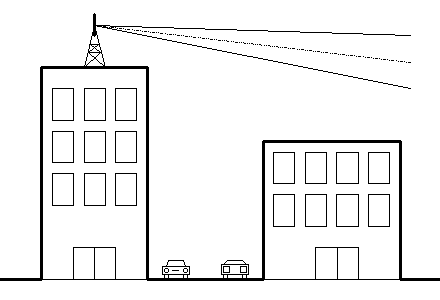 |
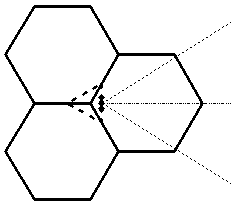 |
Nella prossima figura, infine, facendo riferimento alla stessa situazione ed ipotizzando inoltre una potenza EIRP di 1 kW, si mostrano schematicamente le aree sul piano verticale entro le quali sono rispettati i limiti di sicurezza italiani per le esposizioni di breve durata e prolungate (durata maggiore di 4 ore).
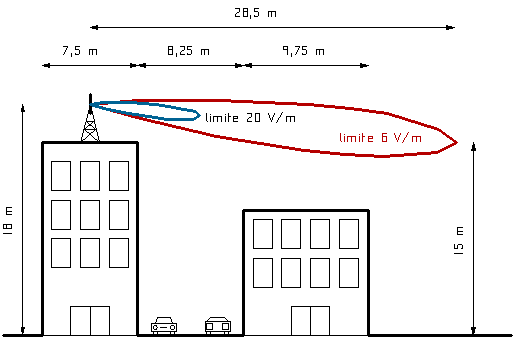
Confronto TV - telefonia GSM
Torna all'inizio
Torna all'indice dei contenuti
della comunicazione
Torna alla pagina
iniziale della conferenza
Daniele Andreuccetti, IROE-CNR, 2000.